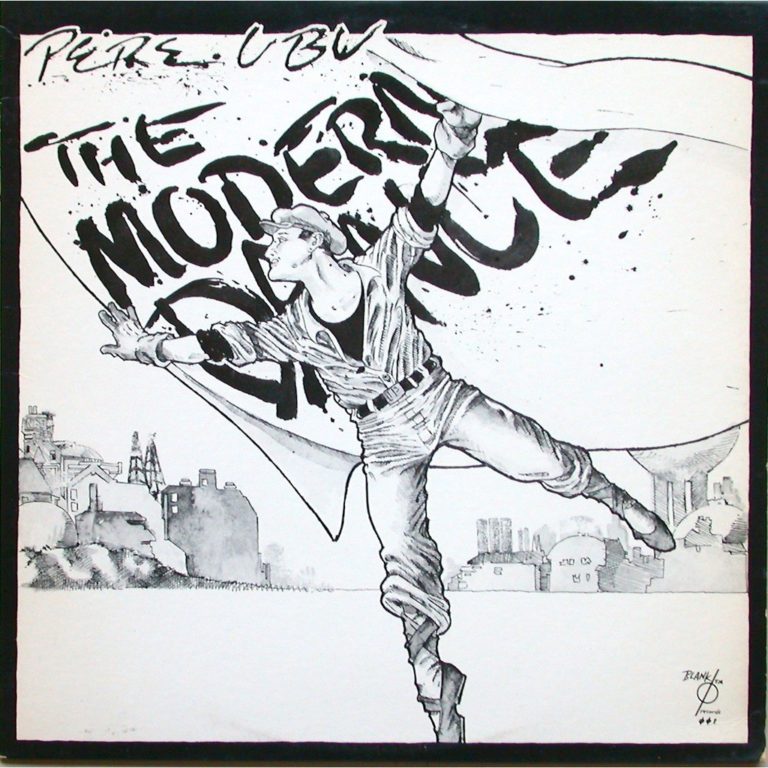La leggenda narra che due rockettari, Bernard Sumner (chitarra) e Peter Hook (basso) si incontrino a Manchester, la loro città, il 4 giugno del 1976. Spinti da una performance (che è anche il loro primo concerto) dei Sex Pistols, decidono di formare loro stessi una band.
Sull’onda di una totale e radicale rifondazione musicale, cercano e incontrano l’aspirante poeta Ian Curtis. Partono facendosi chiamare Warsaw in onore della canzone “Warszawa” di David Bowie, per poi cambiarlo in Joy Division nome usato nei campi di concentramento nazisti dove venivano internate le donne destinate a soddisfare il sinistro piacere degli ufficiali con la croce uncinata. Nell’Inghilterra dei fine anni ’70 travolta dal punk la provocazione era diventata norma, persino abitudine.
Circolavano voci strane su di loro e sul loro cantante, Ian Curtis, quello che nelle foto guardava da un’altra parte. Si muoveva in modo stranissimo e si diceva che sul palco simulasse crisi epilettiche. Si seppe poi, che epilettico lo fosse davvero.
Quest’album d’esordio aveva un che di realmente inquietante, non era teatro, non era provocazione, era pura disperazione. La copertina nera (firmata Peter Saville) ne è l’esempio.
Le canzoni sono un muro sonoro avvolgente e incalzante insieme. Sono melodie introspettive, cariche di commozione e timore. Sono canzoni “maledette”, spettrali e sofferte.
Il geniale produttore Martin Hannett riesce ad impossessarsi del gruppo fino a cambiarlo radicalmente, e anche merito suo, l’esser riuscito a scovare dalle viscere dei musicisti, quel suono oscuro, nero, a volte spaventoso, a volte straziante… Curtis canta (come Jim Morrison, che venera) testi che parlano di nevrosi, alienazione, malattia, Hannett rallenta i pezzi fino a renderli ipnotici, perversi. La batteria è signora assoluta del suono, basso e chitarra sono al suo servizio.
In poco tempo i J.D. si fanno conoscere e alimentano un vero culto. La fama cresce, e non solo in Gran Bretagna, ma il suicidio di Curtis (nel maggio 1980, a ventiquattro anni) alla vigilia dell’uscita del secondo album e del primo tour americano, mette fine alla band e la fa entrare nella leggenda nera del rock’n’roll.
Cominciano gli anni Ottanta, i Joy Division non ci saranno più, e al rock mancherà qualcosa di importante.