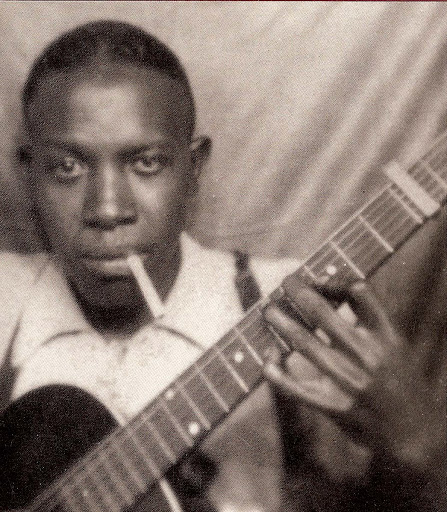The Band & Robbie Robertson
The Band – Una sola formazione merita l’appellativo di “band più importante della musica americana degli anni Settanta” ed è stata quella di R. Robertson, R. Danko, L. Helm, G. Hudson e R. Manuel, ovvero la Band, il massimo riconoscimento al più nobile artigianato della musica. Tra il 1958 e il 1963 la Band entrò nella storia del rock suonando alle spalle di un Bob Dylan alla ricerca dell’elettricità.
La Band arrivava da un repertorio forte, ballabile e nero. Dylan portava con sè il proprio repertorio folk e country: l’insieme fu straordinario, dal vivo come in studio (basta riascoltare i Basement Tapes). Prima di Dylan i musicisti del gruppo non componevano le proprie canzoni, dopo l’incontro con il folksinger Manuel, Robertson e Danko iniziarono a mettere mano alle composizioni con risultati eccellenti. E’ con “Music from Big Pink”, del 1968, che la band mostra davvero se stessa al mondo. Il gruppo cantava e suonava come cinque distinte individualità che lavoravano insieme per lo stesso obbiettivo. C’era un suono collettivo ma era fatto da cinque persone differenti, da cinque voci e strumenti che mescolavano insieme folk, blues, gospel, r’n’b, classica e rock’n’roll. Era la musica americana, la storia della musica popolare americana, che veniva celebrata nella maniera più moderna e straordinaria da un gruppo di canadesi (tranne L. Helm) che sembravano conoscere gli Stati Uniti e la loro musica meglio di chiunque altro. Il secondo album, “The Band” del 1969, mostrò una formazione che era riuscita ad affinare ulteriormente le proprie doti compositive; “Stage Fright” del 1970, aggiunse alla già ricca poetica del gruppo il fascino del rock vissuto “on the road”. Gli anni dal 1971 al 1975 li vedono tornare in studio per “Cahoots” (1971), non particolarmente brillante, per un live, “Rock of Ages” (1972) e per una collezione di standard degli anni cinquanta “Moondog Matinee” (1973).
Ma è con Dylan che la Band tocca i suoi vertici, in “Planet Waves” del 1974 e nel travolgente “Before the Flood” del 1975, che i musicisti della Band segneranno con le proprie canzoni e con le proprie performance, sia da soli sia con Dylan, anzi, più da soli che con Dylan, una delle più belle stagioni della musica americana. Con lo straordinario “The Last Waltz” del 1978, firmato da Martin Scorsese, realizzeranno il più bell’epitaffio della loro straordinaria storia musicale.
Robbie Robertson – Dallo scioglimento della band nel 1976, R.R. scelse di allontanarsi dalla canzone e iniziare una collaborazione con Martin Scorsese che lo porterà, negli anni Ottanta, a firmare le colonne sonore di “Raging Bull”, “The King of Comedy” e “The Color of Money” (rispettivamente, “Toro Scatenato”, Re per una Notte” e “Il Colore dei Soldi”. Ma il cinema, nonostante il successo, non era abbastanza. Il ritorno alla canzone, anzi l’esordio come solista, arrivò nel 1987 con la pubblicazione del primo disco “Robbie Robertson”, realizzato con la collaborazione dei vecchi amici Rick Danko e Garth Hudson, ma soprattutto di Daniel Lanois e Peter Gabriel, un album essenziale per comprendere come la canzone americana degli anni Ottanta fosse uno straordinario crogiuolo di esperimenti, commistioni, rimescolamenti. Il disco di Robertson (seguito nel 1991, da “Storyville”, dedicato alla musica di New Orleans e, nel 1994, da “Music for the Native Americans”, un progetto teso al recupero delle sue radici indiane) fu uno dei migliori esempi del rinnovamento del rock, un esperimento riuscito di fusione tra l’eredità degli anni Settanta e le nuove sensibilità della musica nata dopo l’esplosione del punk. Per la prima volta, soprattutto, il rock degli States dedicava in maniera compiuta le proprie energie creative al recupero della musica indiana, l’unica a essere totalmente ignorata dal “melting pop” americano, in conseguenza di un atavico e poco elaborato senso di colpa nei confronti dello sterminio dei primi, originari, abitanti del Nuovo Mondo.