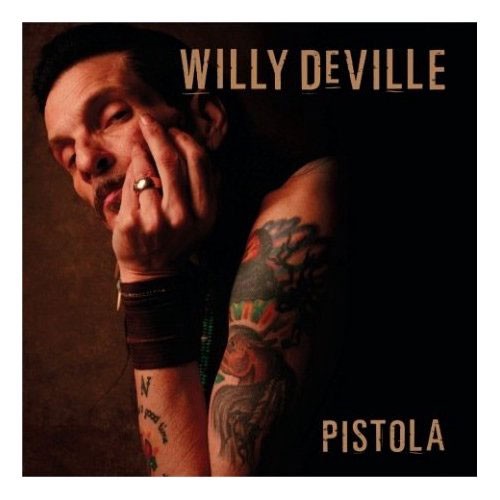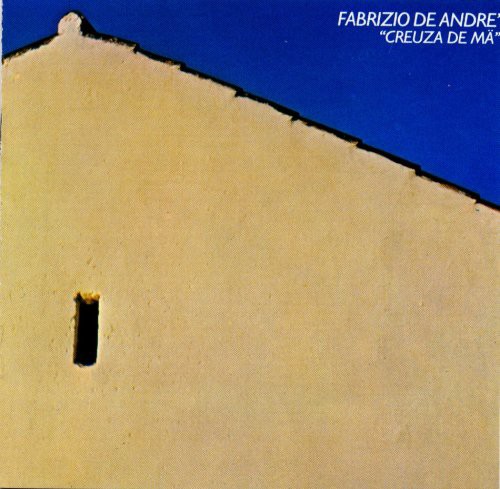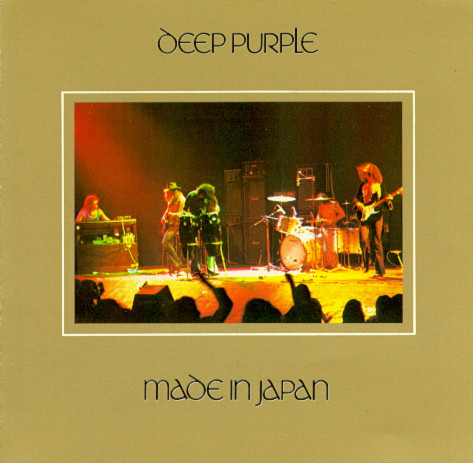Prefazione — Disco considerato come uno dei massimi capolavori non solo della musica italiana, ma della musica tutta. Attribuire questo disco a De Andrè è un po’ limitativo visto che l’apporto musicale di Pagani è non solo determinante ma in egual misura direi anche “sonoramente marcante”. In questi trentasette anni dall’uscita del disco, ammetto di averlo ascoltato fino quasi alla nausea (che non mi è mai venuta), assaporandolo in ogni sua minima sfumatura, nei suoni e nei testi, cercando di cogliere il significato più profondo che i due musicisti hanno voluto esprimere. Proprio per questo l’articolo è più lungo e dettagliato.
Il disco — Un disco italiano ma non in italiano, anzi in genovese antico. L’album infatti nasce dall’incontro tra De Andrè e Mario Pagani, uno dei maggiori musicisti italiani. L’idea è stata quella di concepire un album “mediterraneo” nell’origine, andando a pescare in giro per il bacino del nostro mare gli strumenti che le civiltà dall’origine avevano tramandato.
La malinconia che mi avvolge, quando ascolto la voce di Fabrizio De Andrè, è ancora tanta. Malinconia e senso di vuoto. Creuza de ma è uno dei tanti bellissimi dischi incisi da De Andrè, potrei banalmente definirlo un capolavoro, se non mi fosse difficile, per non dire impossibile, stilare una classifica delle sue composizioni. Una cosa differenzia questa raccolta dalle altre opere di Fabrizio De Andrè: tutti i brani di questo disco sono stati scritti e cantati in genovese. Ma anche in questa veste, pur nella difficoltà della comprensione del dialetto per chi genovese non è, la poesia è intatta, la magia e l’incanto delle atmosfere che De Andrè riusciva a creare, immutati. Intanto la musica, linguaggio universale che parla direttamente al cuore; poi la voce calda e scandita di Fabrizio De Andrè, inconfondibile e bella, pur se non estesa, che culla l’ascoltatore. Infine la sua poeticità, la sua delicatezza e la sua sensibilità, la sua ironia, che si esprimono magistralmente anche con l’uso del dialetto.
CREUZA DE MA’ – Il brano omonimo apre il disco sulle note dell’assolo di gaita (un tipo di cornamusa) e poi si sviluppa quasi esclusivamente su un tappeto ritmico-melodico-percussivo e sulla voce di De André. Sono le percussioni a parlare principalmente, nella musica mediterranea come nella musica nero-africana. “La mulattiera di mare” del titolo, è un primo grande affresco della vita alle soglie dell’acqua salata e racconta l’amore, l’amicizia, la delinquenza, gli odori e i sapori. È il primo colpo di genio della poetica del genovese ed è un colpo che tramortisce. Il brano si conclude con i rumori e le voci del mercato del porto di Genova, registrati in presa diretta da quel che ricordo. Le voci dei mercanti si fondono con la musica del brano successivo, il capolavoro musicale del disco, per quanto mi riguarda.
JAMIN-A — Straordinaria canzone: fosse stato comprensibile direttamente, il testo di “Jamina” avrebbe subito le ire censorie, non ho alcun dubbio. Jamina non è una prostituta, è LA prostituta, un corpo bollente prima ancora che un essere umano, un corpo che De André descrive quasi senza parlare della persona: “Mi voglio divertire/nell’umido dolce/del miele del tuo alveare”. Jamina deve farsi guardare, non servono parole: “Dove c’è pelo c’è amore/sultana delle troie”. Il corpo femminile come alveo dell’insopprimibile voglia di soddisfacimento sessuale degli uomini, raccontato da De André, che sulle prostitute ha imbastito alcuni dei suoi massimi capolavori letterari in musica.Musicalmente, il brano è altrettanto straordinario. Ancora un timido tappeto percussivo iniziale sulla voce, ma poi sono gli strumenti orientali a sommergere il tutto con la loro melodia. In questo caso, deliziano i padiglioni auricolari l’oud e il bouzouki, strumenti a corda di origine araba il primo e greca il secondo. I contrappunti ritmici e le lontane suggestioni melodiche, fanno di “Jamin-a” uno straordinario viaggio, da commozione pura.
SIDUN“ – Sidun” (Sidone) è il lamento di una madre palestinese per il proprio figlio morto, una ballata funebre che unisce il dialetto genovese al dramma mediorientale, in una comunione mediterranea di inenarrabile forza struggente. “Tumore dolce benigno/di tua madre”, canta De André, in un momento, il 1984, che doveva ancora vedere la nascita della prima “intifada”: “e ora grumo di sangue orecchie/e denti di latte”. Il lento dipanarsi del testo, accompagnato da uno strumento turco, lo shannaj, giunge sino a un punto quasi insostenibile a livello drammatico e di commozione, quando, sul finale, la musica sembra aprire uno scenario di speranza, proprio quando il testo conclude la sua narrazione del dramma di una madre. È a quel punto che la melodia si addolcisce, si arricchisce delle percussioni e si apre a una visione quasi solare per voce e strumenti. Devo ripetermi: un altro momento straordinario.
SINÀN CAPUDÀN PASCIÀ – “Sinàn Capudàn Pascià” racconta una storia dell’epoca della Repubblica Marinara genovese, quando un marinaio ligure catturato durante uno scontro con la flotta turca, Cicala, diventò un Pascià turco con il nome del titolo, sembra per merito del suo aspetto gradevole e della sua giovane età. Lo scontro militare avvenne davanti alle coste tunisine ed è così che la musica si accosta alla cultura maghrebina e Kabil, mentre il testo punta moltissimo sull’ironia e lo sberleffo sarcastico (“La sfortuna è un cazzo/che vola intorno al sedere più vicino”). Il ritornello riprende un motivo popolare che si vuole usuale tra le genti tirreniche: “In mezzo al mare c’è un pesce tondo/che quando vede le brutte va a fondo/In mezzo al mare c’è un pesce palla/che quando vede le belle viene a galla”. Una canzone che, a dispetto del suo incedere fortemente percussivo, sembra cantata e suonata in punta di piedi.
‘A PITTIMA – La pittima è colui che si lamenta, che rompe le scatole per qualsiasi cosa. La traduzione del foglietto del cd, riporta il termine dal dialetto alla lingua italiana, anche dalle mie parti ha lo stesso significato: persona che si lamenta.In questo caso, la pittima è l’esattore che va in giro a chiedere i soldi dei prestiti lamentandosi di continuo della sua condizione, vista come meschina dalla gente. A livello musicale, è forse il brano meno interessante dell’album, senza guizzi particolari e caratterizzato dalla voce mesta e bassa di De André, in tono, in ogni caso, con il testo.
A DUMENEGA – Canzone sull’ipocrisia e sulla falsità, “A dumenega” racconta di un costume antico della Genova di un tempo, quando alle prostitute, relegate nei ghetti durante la settimana, alla domenica veniva concesso di passeggiare per la città. Con un linguaggio sboccatamente popolare, De André racconta degli scherni della gente “normale” verso le prostitute in libera uscita, le stesse che comandano sui sensi di quella gente durante la settimana. Il testo, spiace ripetersi, è straordinario per l’uso sopraffino dei termini volgari e delle rime, con un colpo di scena finale di squisita ironia, quando il portatore della croce nelle processioni, scorge tra le prostitute la propria moglie, “mestierante” per guadagnare il pane.Il brano ha il sapore medievale dell’ambientazione narrativa ed è stupendo.
DA ME RIVA – Conclusione affidata a una tenue ballata che riporta il filo narrativo nel porto di Genova, dove era iniziato. Il marinaio lascia ancora una volta la sua bella sulla riva e la pensa mentre anche lei sta sicuramente guardando il mare. Il ricordo è affidato a una foto: “La tua foto da ragazza/per poter baciare ancora Genova”. Un finale struggente e malinconico, triste come può esserlo la vita del marinaio sempre in partenza, sempre sulle onde del mare “un po’ più al largo del dolore”. In fondo, un’ode di De André alla propria città.
Che dire di più, ogni canzone suscita emozioni, belle, allegre, tristi. Ogni canzone è una poesia musicata. Ogni canzone è il cuore di Fabrizio De Andrè. Sorrisi e lacrime, come sempre. Sorrisi e lacrime, ancora oggi, nel ripensare al grande poeta che non c’è più.