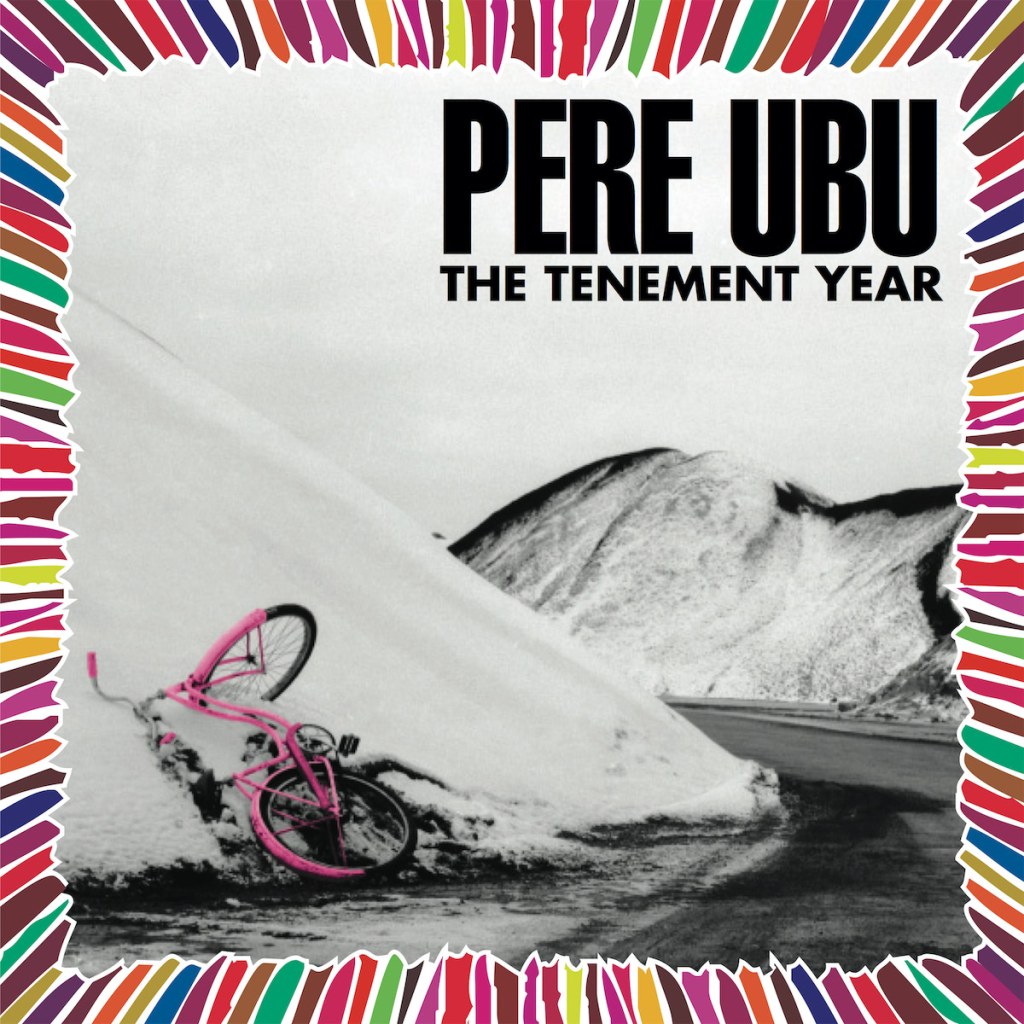17 – Il “Kraut Rock”
Sotto l’infelice definizione di kraut rock si trovano raggruppati gruppi diversissimi tra loro, ma accomunati dalla nazionalità tedesca e da una certa predisposizione a fusioni inedite di rock ed avanguardia (dal minimalismo di Riley all’avanguardia elettronica di Stockhausen) filtrate attraverso la tradizione musicale teutonica, da Wagner al cabaret di Brecht e Weill.
Come per il primo progressive inglese per molti di questi gruppi viene dalla psichedelia, dalle lunghe jam e dal bisogno di espandere la canzone oltre i limiti tradizionali, in termini di durata e struttura, ma anche in termini stilistici.
Un ulteriore elemento di similarità tra gli artisti tedeschi di questi anni sta nel pionieristico utilizzo di strumenti elettronici: sintetizzatori, sequencer e drum machine cominciano per la prima volta ad affiancare (e talvolta a sostituire) gli strumenti tradizionali del rock.
Elementi comuni rilevanti, ma spesso superficiali, se si considera che le scelte stilistiche e le atmosfere create da questi gruppi sono spesso antitetiche, dalla musica cosmica dei Tangerine Dream al proto synth pop dei Kraftwerk passando per l’avant-prog visionario dei Can.
Proprio questi ultimi sono tra i primi gruppi della scena ad emergere: avanti anni-luce rispetto ai contemporanei nell’esplorare le potenzialità dell’utilizzo di strumenti elettronici, nell’integrare il proprio avant-rock con tecniche di taglia-e-incolla, rumorismo, minimalismo, musica atonale ed aleatoria. Dall’esordio psichedelico di “Monster Movie” (1969) passando per capolavori come “Tago Mago” (1971) ed “Ege Bamyasi” (1972) fino ad arrivare a “Future Days” (1973) i Can disseminano così tanti spunti e idee che ci vorranno poi anni, se non decenni, per rielaborarli tutti: il post rock, il dream pop, tanta elettronica indie sono solo alcuni dei suoni che passano forzatamente di qui, tra i ritmi spezzati di “Vitamin C” e le armonie circolari di “Sing Swan Song”.
Diversissime le atmosfere che permeano i solchi di “Phallus Dei”, debutto del 1969 degli Amon Duul II: un suono psichedelico pervaso da un tetro spirito gotico, dalla furiosa jam dissonante di “Luzifers Ghilom” ai canti medievali che infestano “Henriette Krofenshwanz”, due episodi a caso di un disco sempre e comunque dominato da un’atmosfera raggelante che raggiunge l’apice con l’ultima traccia del disco, quella “Phallus dei” che gli da anche il titolo.
Sono simili le atmosfere che si respirano nell’esordio omonimo dei Faust (1971), che è però scaldato da sonorità diverse: altri grandi pionieri musicali dell’epoca, i Faust portano nel mondo del rock la musica concreta e il collage sonoro, in un susseguirsi caotico ed assurdo di rumori trovati, campioni rubati e suoni siderali. Più convenzionale sull’altro capolavoro, “IV” (1973), il gruppo costituisce un’altra dimostrazione del valore seminale della scena tedesca, precursore di sonorità che ritroveremo decenni dopo nel post rock e negli esperimenti più azzardati della cosiddetta IDM (Intelligent Dance Music).
Altrettanto seminali per tanta musica strumentale e ambientale a venire, dalla new age degli anni ’80 alla techno ambient di metà ’90 le derive sonore dei Tangerine Dream: le esplorazioni interstellari cominciano nel 1970 con l’esordio “Electronic Meditation” e trovano nelle jam di tastiera, flauto e percussioni di “Alpha Centauri” (1971) una prima, sfocata, definizione: musica cosmica (kosmische musik) fluttuante nel vuoto e apparentemente priva di una struttura che la tenga unita che raggiunge lo stato di trance con “Phaedra” (1974) per poi, durante gli anni ’80, omologarsi in parte al suono new age che aveva contribuito a creare.
Si torna bruscamente con i piedi per terra, schiantandosi contro i ritmi nevrotici della realtà urbana, con la musica dei Kraftwerk: primo gruppo ad utilizzare una drum machine in “Kraftwerk 2” (1971), il gruppo mostra qui le due anime, quella sperimentale e quella pop.
La lunga suite di “Klingklang” alterna, procedendo su un ritmo schizofrenico, musica concreta, classica, orientale, psichedelica: accanto a flauto, violino e tastiera fa la sua comparsa per la prima volta l’incedere marziale della batteria elettronica mentre la voce latita per tutto il disco, in un susseguirsi di pezzi astratti e circolari come “Wellelange” (ancora un’anticipazione del post rock) e collage sperimentali e umoristici come “Atem”.
Radicalmente differenti, ma ancor più seminali, i Kraftwerk di “Autobahn” (1974) che portano per la prima volta le sperimentazioni elettroniche tedesche in territorio pop, mettendo i ritmi meccanici della drum machine e le tastiere elettroniche al servizio di una musica di più facile consumo: un’intuizione folgorante che pone le basi per la nascita dell’electro e del synth pop e che anticipa le intuizioni della disco elettronica di Giorgio Moroder.
Da due ex-Kraftwerk, Michael Rother e Klaus Ginger vengono formati nel 1971 i “Neu!”, gruppo che brilla fin nell’omonimo esordio del 1972 e in “Neu!2” (1973): pattern melodici e ritmici circolari si inseguono ossessivamente, con sonorità che anticipano la new wave più avanguardista, il post rock più elettronico e lo space pop più obliquo, (ma anche per gli stessi Kraftwerk di Autobahn) e che tenderà a stemperarsi e ammorbidirsi nei dischi successivi.
Precursori e profeti della new age i Popol Vuh, con un suono ambientale e sacrale in cui compare per la prima volta la voce spiritata del moog: “In den Gärten Pharaos” (1971), disco composto di due lunghe suite della new age, oltre al suono dilatato e sospeso, anticipa anche l’utilizzo di mantra ritmici importati dall’oriente. Nel successivo “Hosianna Mantra” il gruppo abbandona gli strumenti elettronici in favore di quelli acustici spingendo ancora più in là l’integrazione tra oriente ed occidente, in un enigmatico incrocio tra messa cristiana e meditazione Buddista.
E’ impossibile tenere il conto dell’influenza esercitata da questi musicisti su tutta la musica futura, elettronica e non, tante sono le idee sviluppate in così pochi anni e nel giro di una manciata di dischi: influenze che sono state messe a frutto in contesti diversissimi e con modalità spesso contrastanti. Attraverso un uso pionieristico delle nuove tecnologie elettroniche ed una commistione visionaria con le avanguardie che fino allora erano rimaste quasi completamente slegate dalla realtà del rock (se per questi gruppi di rock si può ancora parlare), ma anche attraverso una contaminazione con una tradizione melodica come quella teutonica, completamente estranea rispetto alla cultura che aveva prodotto il rock, i gruppi del cosiddetto kraut rock hanno disseminato una quantità sterminata d’idee ed intuizioni: parte di quei semi, probabilmente, deve ancora maturare. (Continua…)
(Materiale scritto ed elaborato insieme al gruppo ‘Storia della Musica’)