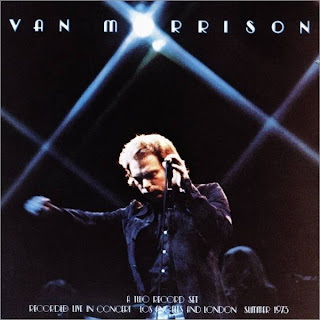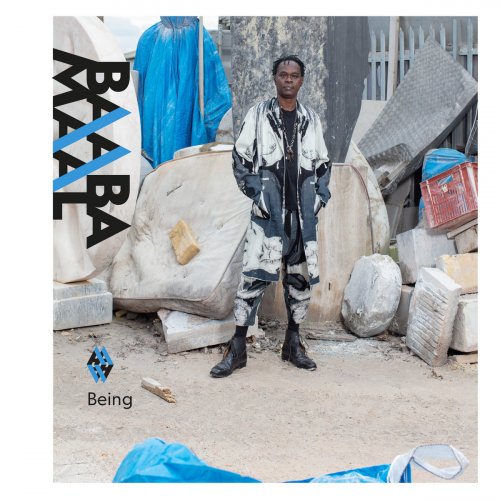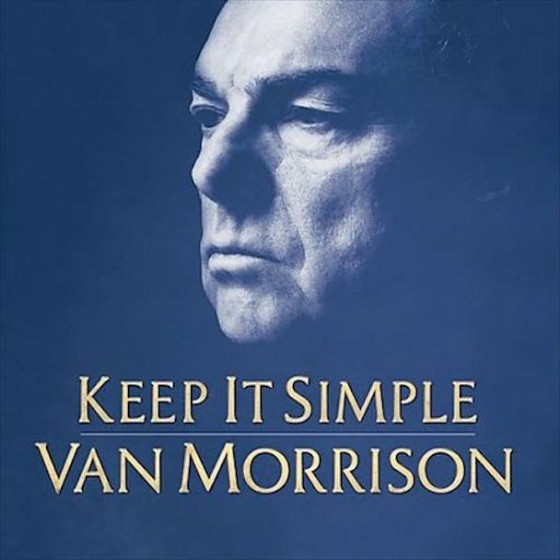Van Morrison insieme a John Mayall e Eric Burdon che vedremo nei prossimi post, decisero a fine anni Sessanta di trasferirsi in America per cercare una svolta alla loro carriera musicale, dando fortunatamente il via anche ad un periodo estremamente fecondo, musicalmente parlando.
Van Morrison veniva da una famiglia protestante di Belfast, amante della musica: sua madre era una cantante, piena di fervore religioso che nel tempo diventerà Testimone di Jehovah, mentre il padre era collezionista di album americani di jazz e blues. I musicisti più ascoltati a casa Van furono Ray Charles, Solomon Burke e sopra tutti Leadbelly.
Andò via di casa a 15 anni e prima di entrare a far parte del gruppo di covers dei Monarchs, suonò con complessi skiffle e rock and roll. Il suo canto era una via di mezzo tra Mick Jagger e Eric Burdon e il suo fraseggio era spesso forzato e innaturale. Sul palco era incredibile, si buttava per terra, si denudava, ballava sui tavoli.
Riuscirono anche ad andare in tour in Germania dove ebbero la fortuna di esibirsi davanti ai GI’s americani. Van vide dal vivo i Downliners Seet, li volle copiare e fondò i Them. Arrivato a Londra, si affidò al produttore Bert Berns che aveva da poco formato l’etichetta Bang!, il cui distributore inglese era la Decca.
Con i Them raccolse numerosi successi, il maggiore dei quali fu Gloria, ma vale la pena citare almeno Baby Please Don’t Go (con una schitarrata rabbiosa di Jimmy Page, allora ancora sessionman) e Here Comes The Night (scritta da Bernie, sempre con Page, che sarà ripresa successivamente da Bowie in Pin-Ups). Il 1966 fu l’anno del suo primo tour americano, al ritorno del quale sciolse la band e lasciò la musica. Fortunatamente Bert Berns lo persuase a ritornare a New York e a registrare materiale da solista sempre per l’etichetta Bang!. Da queste session nacque una delle sue canzoni più famose, Brown-eyed Girl, che raggiunse il decimo posto delle classifiche USA nel 1967, quando Van era ancora praticamente sconosciuto in madre patria. L’album si chiamerà Blowin’ Your Mind!, e le registrazioni complete verranno pubblicate nel 1991 dalla Bang Masters.
La morte di Berns avvenuta nel 1967 lo portò a vivere prima a Cambridge (Massachusetts) e poi a Boston. Dopo un periodo di depressione e di problemi con l’alcool, dovuto al fatto di non trovare ingaggi e di non sapere bene cosa fare, si trasferì a Los Angeles, dove riuscì ad incidere per la Warner Bros; Astral Weeks.
L’album, un impasto di poesia irlandese e di innovative sonorità folk-jazz, uscito nel 1968, fu acclamato dalla critica, ma ricevette una fredda accoglienza da parte del pubblico. Contiene diverse gemme come Sweet Thing, Cyprus Avenue, Ballerina, Beside You e Madame George, ed è uno dei pochi dischi spartiacque, che fece capire come fosse possibile per la musica pop liberarsi da schemi, preconcetti e canoni. Probabilmente la breccia nella quale s’infileranno musicisti come Nick Drake, Tim Buckley o Richard Thompson. Nel disco compaiono jazzisti illustri come Connie Kay (batterista del Modern Jazz Quartet), Richard Davis e Jay Berliner.
Morrison si trasferì a Woodstock, vicino di casa di Dylan e della Band, due anni dopo pubblicò Moondance che raggiunse la 29ª posizione della classifica curata da Billboard. Se il predecente era un album intriso di tristezza e tenerezza, Moondance rivela invece un animo ottimista ed allegro, è meno avventuroso del precedente ma molto più vario, in cui l’autore fissa il suo stile e cristallizza tutte le sue influenze nere: blues, jazz, soul, gospel.
Negli anni immediatamente successivi cominciò a temere il palco e il pubblico molto numeroso. Dopo un breve distacco dalla musica, ricominciò ad esibirsi nei club e riconquistò la sua abilità istrionica, sebbene dinanzi ad un pubblico più ridotto. Riuscì anche ad accettare un invito di Bill Graham per suonare al Fillmore East. Nel 1970 si esibì in due date insieme ai Brinsley Schwartz e ai Quicksilver Messenger Service, poi una volta con gli Allman Brothers e i Byrds a settembre e l’anno successivo a febbraio tenne quattro concerti in due giorni, pomeriggio e sera, con i Fleetwood Mac e Peter Green, che aveva lasciato la band un anno prima, ma era stato richiamato per sostituire Jeremy Spencer, scappato durante il tour con la setta dei “Bambini di Dio”. Green impose alla band di suonare solo un’interminabile psichedelica Black Magic Woman che avrebbe fatto la gioia dei Dead ma non certo di Van Morrison, che ne fu alquanto seccato. Green voleva anche che i compagni distribuissero ai poveri il loro ingaggio ma gli altri non accettarono.
Pubblicò diversi altri album di successo (His band and the Street Choir del 1970, Tupelo Honey del 1971 e Saint Dominic’s Preview del 1972, l’album doppio It’s Too Late to Stop Now, da molti riconosciuto come uno dei più grandi album dal vivo nella storia del rock, l’introspettivo e triste Veedon Fleece del 1974), ma sono spesso dischi disomogenei con piccole gemme sparse come Domino (9° negli USA nel 1970), I Wanna Roo You, Wild Night, Jackie Wilson Said, Listen To The Lion, Almost Independence Day, la cupa Snow In San Anselmo Autumn Song, Country Fair, You Don’t Pull No Punches, Streets Of Arlow, Linden Arden, Kingdom Hall, Venice USA, Wavelength, Listen Arden Stole The Highlight….
I suoi dischi non saranno mai più semplici raccolte di canzoni, ma diari spirituali in cui l’animo sembra lacerato dai temi universali della vita e della morte.
Nel 1976 partecipò al concerto di addio della Band The Last Waltz.
Continua a sfornare dischi.