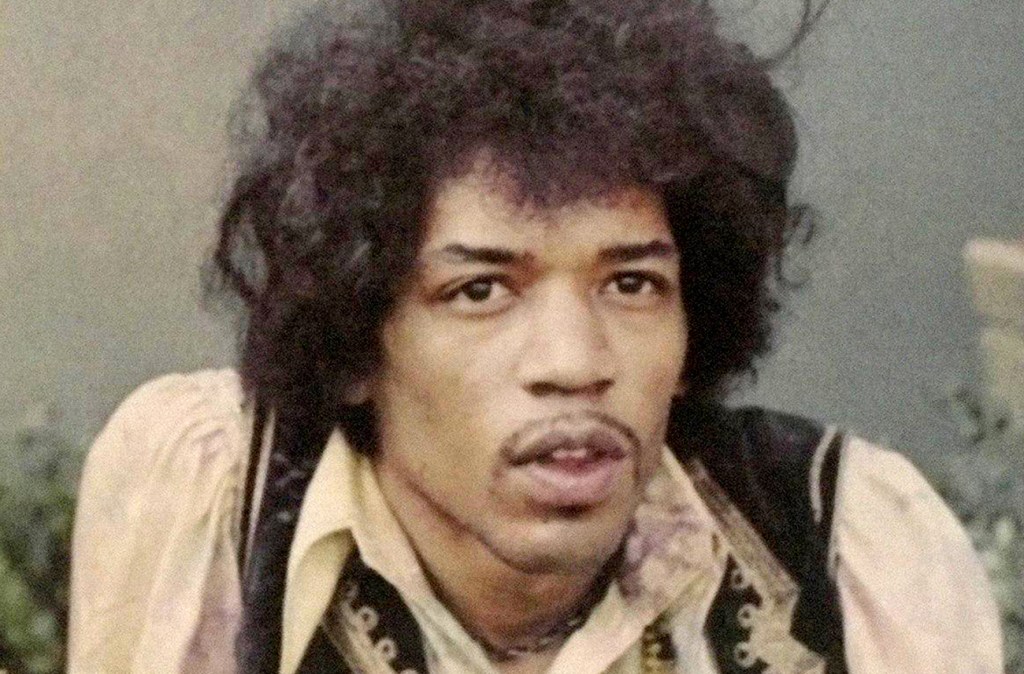Have A Little Faith – John Hiatt #3/10
Dati
Have a Little Faith in Me è un brano musicale scritto e interpretato da John Hiatt, che appare nel suo album “Bring the Family“.
Dopo sette dischi pubblicati in studio, il primo risale al 1974, nel 1987 incide il suo ottavo album ed è quello che lo porta al successo planetario. Hiatt ha trentacinque anni ed è reduce da una serie di fatti luttuosi che lo mandano in depressione ma grazie ad una cerchia di amici musicisti, registra “Bring the Family” che in qualche modo ne dichiara la rinascita. Un nuovo amore e una nuova vita danno la forza di continuare. Il passato è ieri e oggi è il domani.
Questo disco è un sogno ed è la fine di un incubo.
Tra gli artisti che hanno eseguito la cover del brano vi sono:
Bill Frisell in versione strumentale nell’album Have a Little Faith (1992);
Joe Cocker nell’album Have a Little Faith (1994);
Jewel per la colonna sonora del film Phenomenon;
Jon Bon Jovi per il film Capodanno a New York.
Mandy Moore, che lo ha pubblicato come singolo nel 2003 estratto dall’album Coverage.
Pensiero
Difficile trovare una canzone che non sia all’altezza in questo album, poi facendo una grande selezione, “Have A Little Faith” è probabilmente la più significativa, per il testo e per il suono che il questo caso si limita ad un pianoforte, e che pianoforte!
Piano e voce che per quattro minuti si intrecciano come la trama e l’ordito. Un piano ‘battente’ con pochissime note, quasi a tenere il passare del tempo e la voce profonda e lirica che pochi sanno utilizzare come Hiatt.
Non c’è molto altro da aggiungere su questa canzone, il testo tradotto, come al solito non rende merito al brano ma in qualche modo rende l’idea del momento che sta attraversando.
Quando la strada si fa buia e non riesci più a vedere
Lascia che il mio amore getti una scintilla e abbi un po’ di fiducia in me
E quando le lacrime che piangi sono tutto quello in cui puoi credere
Permetti a queste amorevoli braccia un tentativo e abbi un po’ di fiducia in me
E quando il tuo cuore segreto non riesce a parlare così facilmente
Vieni qui tesoro, inizia con un sussurro ad avere un po’ di fiducia in me
E quando sei con la schiena al muro basta che ti giri e vedrai, tu vedrai
Ti prenderò, fermerò la tua caduta solo abbi un po’ di fiducia in me
E abbi un po’ di fiducia in me beh, ti ho amata per così tanto tempo ragazza
Non aspettandomi nulla in cambio solo che tu avessi un po’ di fiducia in me
Vedi il tempo, il tempo è nostro amico perché non c’è fine per noi
E tutto quello che devi fare è avere un po’ di fiducia in me, ho detto che ti sosterrò, ti sosterrò
Il tuo amore mi dà abbastanza forza perciò abbi un po’ di fiducia in me
Ho detto ehi, tutto quello che devi fare per me è avere un po’ di fiducia in me.