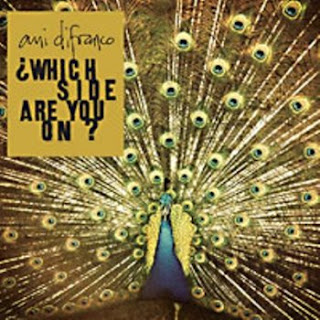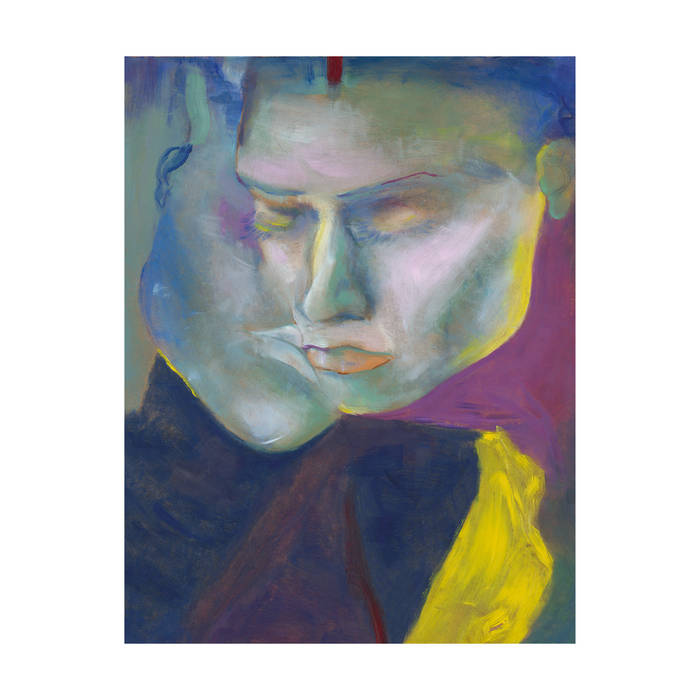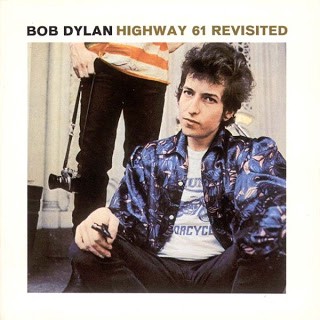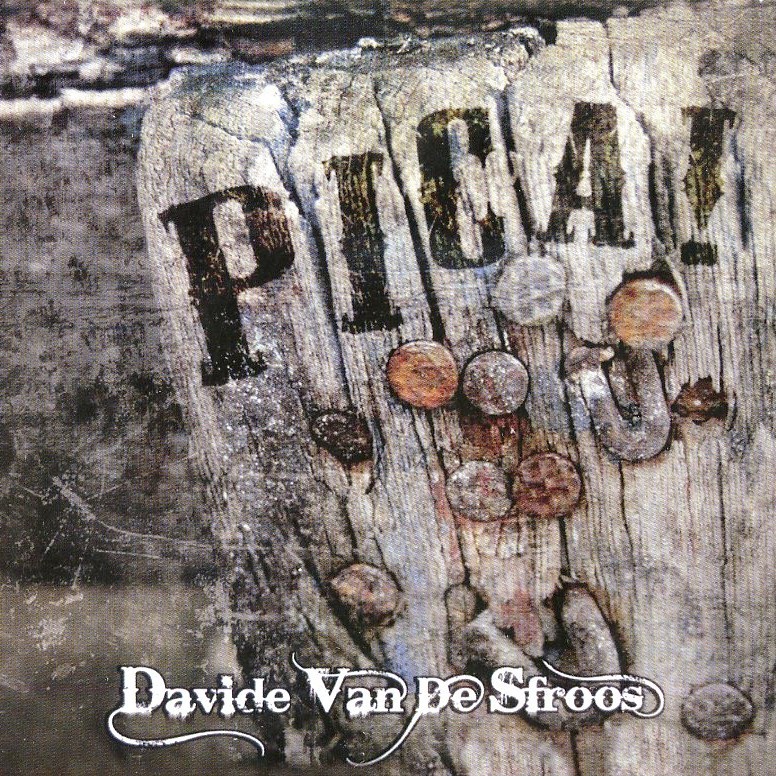Miles Davis
Nel periodo che va dagli anni Cinquanta al decennio successivo, il jazz attraversò una stagione di straordinaria e dirompente creatività, scandita da alcune personalità di eccezionale valore, musicisti in grado di portare a definitiva maturazione il potenziale della musica afroamericana, musicisti capaci di produrre non solo uno stile, ma una vera e propria «visione» del mondo. Primo fra tutti Miles Davis.
Davis (trombettista, compositore, arrangiatore) è stato un maestro oscuro e regale, un artista dal segno inconfondibile e penetrante. Nei quasi cinquant’anni della sua carriera ha saputo illustrare, con l’evoluzione del suo suono (prima ispirato apprendista del be-bop, poi ombra sottile del cool, poi guru del jazz modale, leader del piú famoso quintetto del jazz moderno, voce misteriosa e notturna e infine trasgressivo contaminatore), il passare delle epoche e degli stili. Ha quasi sempre anticipato il modificarsi delle sensibilità, senza mai adeguarsi alle correnti, piuttosto inventandone, costringendo gli altri a seguire e percorrere le strade da lui indicate. Modernizzatore, organizzatore di talenti e di creatività, Davis ha dilatato la lezione del jazz attraversando le trame culturali del secolo, trasportando la cultura afroamericana al centro esatto del tempo, rappresentato da un’altera e aristocratica purezza, facendo diventare «jazz» qualsiasi materiale sonoro e al tempo stesso costringendo il jazz a una costante ridefinizione dei propri confini.
Nella sua musica scorre il racconto dell’America nera: il ghetto, la violenza, ma anche la fama e la ricchezza, le donne e la droga, l’arte e il malessere, la ribellione e l’apatia di un popolo, il dandismo raffinato e soprattutto la definitiva e non compromissiva emancipazione artistica del suono jazzistico. Miles e come Muhammad Ali, come i discorsi di Martin Luther King, i guanti neri delle Pantere nere di Malcolm X, o la chitarra di Jimi Hendrix, icone di una cultura che negli anni è uscita dai confini fisici e razziali degli Stati Uniti d’America, producendo una sfuggente universalità nella quale si sono riconosciuti uomini di ogni provenienza e intere legioni di musicisti, che non solo hanno fatto tesoro del suo inimitabile stile ma che ne hanno innanzitutto imparato la straordinaria lezione creativa. Davis ha praticato una costante mobilità, evitando che la sua musica si immobilizzasse, diventasse essa stessa «storia».
Nato ad Alton, nell’Illinois, il 26 maggio del 1926 e scomparso il 28 settembre del 1991, Davis è entrato nella leggenda del jazz come trombettista, ma la sua influenza sulla musica contemporanea è dovuta anche al suo lavoro di ispiratore, di bandleader e di compositore. La sua ossessione era la costante mobilità del segno musicale. Mai ripetere e mai sprecare una nota, sembrava sottintendere in ogni performance, e questa naturale vocazione gli ha permesso di attraversare stili e periodi imponendo nuove regole, posizionato sempre all’avanguardia, attento alle possibili nuove strade offerte di volta in volta dagli sviluppi della tecnologia e della creatività. «Quando sento i musicisti di jazz di oggi che suonano le stesse cose di tanti anni fa, mi sento triste per loro. Voglio dire, è come andare a letto con una persona vecchia che puzza anche di vecchio… io amo le sfide, le cose nuove, mi dànno energia», diceva senza mezzi termini Davis, dipingendo la sua ansia del nuovo come una irrinunciabile necessità.