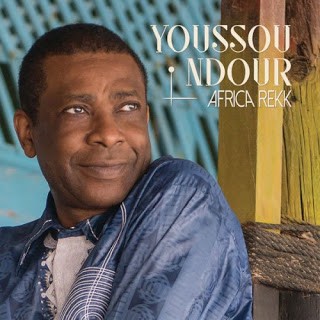Bob Dylan: i suoi album #13
Planet Waves (1974)
Un disco fatto di corsa, pensando ad altro. Con almeno un acuto.
Se si eccettuano sporadiche occasioni, tipo la partecipazione nel 1969 al secondo festival di Wight e ospitate come quelle per il Concert For Bangladesh e il capodanno con la Band alla New York, Academy of Music nel 1972, dal 1966 al 1973 Dylan evita accuratamente i palcoscenici. Da un nuovo incontro con Robbie Robertson a Malibu, però, nasce l’idea di allestire un tour insieme alla Band. E si decide anche di registrare un nuovo Lp, ora che Dylan ha mollato la Columbia per passare alla Asylum. Così, l’artista compone nuovo materiale e con Robertson, Rick Danko, Levon Helm, Richard Manuel e Garth Hudson il 5 novembre del 1973 entra ai Village Recorder di Los Angeles. Produttore accreditato è Rob Fraboni ma in realtà a darsi da fare sono un po’ tutti: “Non c’era un vero produttore per l’album”, racconterà a «Recording Engineer/Producer Magazine» proprio Fraboni. “Ognuno faceva da produttore. Robbie era quello che dava un po’ la direzione, ma tutti avevano qualcosa da dire sulla musica ed erano interamente coinvolti”. La pratica viene sbrigata in quattro giorni con performance praticamente dal vivo (parti vocali comprese), poi il 14 c’è un nuovo appuntamento per incidere Dirge e un’altra versione di Forever Young (sobillato dalla giovane fidanzata di un amico, Dylan giudica la prima troppo sentimentale anche se Fraboni, che invece apprezza, lo convince a infilarle entrambe nell’Lp). Inizialmente, l’opera dovrebbe intitolarsi CEREMONIES OF THE HORSEMEN, da un verso di Love Minus Zero/No Limit di BRINGING IT ALL BACK HOME, ma alla fine si preferisce PLANET WAVES. E per la copertina a pensarci è lo stesso Dylan che, in stile Pablo Picasso, disegna tre figuri, un’ancora, un cuore e il simbolo della pace, e compone le scritte di “Moonglow” (bagliore lunare) e “Cast-Iron Songs & Torch Ballads” (canzoni di ferro duttile e ballate d’amore non corrisposto). Quando esce, il disco azzera la memoria del precedente DYLAN, costruito con un po’ di scarti e pubblicato per vendetta dalla Columbia, ma proprio grande non è. “Lo abbiamo fatto ed è finito prima che ce ne rendessimo conto”, spiegherà Robertson nel 1976 a «Crawdaddy».
“Siamo riusciti a fare molte cose bene in poco tempo. Ma è stato tutto così veloce ed eravamo più preoccupati per il tour e le altre cose che lo accompagnavano. Con tutte le decisioni che dovevamo prendere e tutti i come, i quando e i dove, il disco è davvero passato in secondo piano”. Il pezzo super famoso dell’opera è Forever Young, che Dylan ha scritto tempo prima dedicandolo al figlio maggiore
Jesse. La prima versione è dolce e dura quasi 5 minuti, l’altra, quella registrata il 14, è un veloce country rock sui tre minuti. L’autore parla direttamente al figlio, ma il testo è stato inteso anche come un suo invito a essere “per sempre giovani” a quegli adulti che, persa ormai l’innocenza nonché la speranza, non pensano più che il mondo possa essere cambiato. Dirge, ovvero “canto funebre”, è un altro dei momenti chiave: solo un piano ossessivo, la voce, la chitarra acustica e versi durissimi (“Mi odio perché ti amo e odio la debolezza che dimostro. Eri solo una faccia pitturata in un viaggio verso la via del suicidio”). Ma nel finale, il vicolo non è cieco: “Mi odio perché ti amo, ma sopravviverò”. On A Night Like This e Tough Mama girano bene e molto à la Band, Going Going Gone va di lusso in un blues che vaga nella notte, Hazel è una ballad che afferra nella sua misteriosa intimità. Un po’ di maniera, invece, You Angel You, Never Say Goodbye e Something There Is About You. Per la chiusura, c’è l’acustica Wedding Song, dedicata da Dylan alla moglie Sara che nel corso della registrazione va a sostituire Nobody ’Cept You, in origine prevista per la tracklist e recuperata solo nel 1991 per THE BOOTLEG SERIES VOLUMES 1-3. Quest’utima è una dichiarazione d’amore senza se e senza ma. Nella prima, invece, oltre all’amore c’è anche il timore. La tempesta è in arrivo.