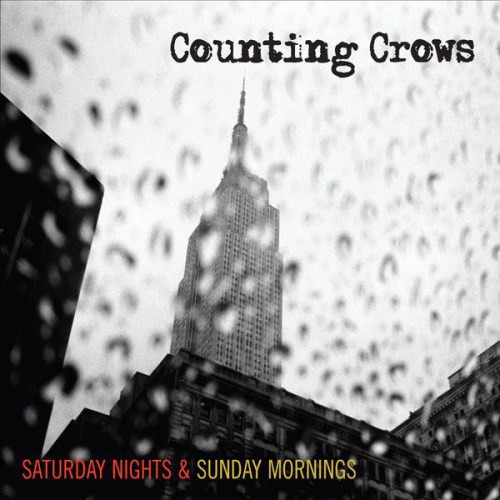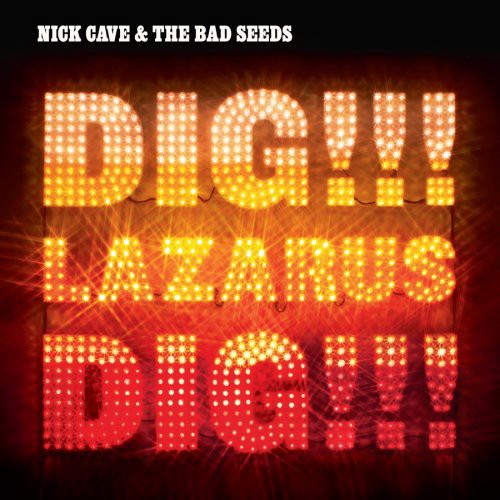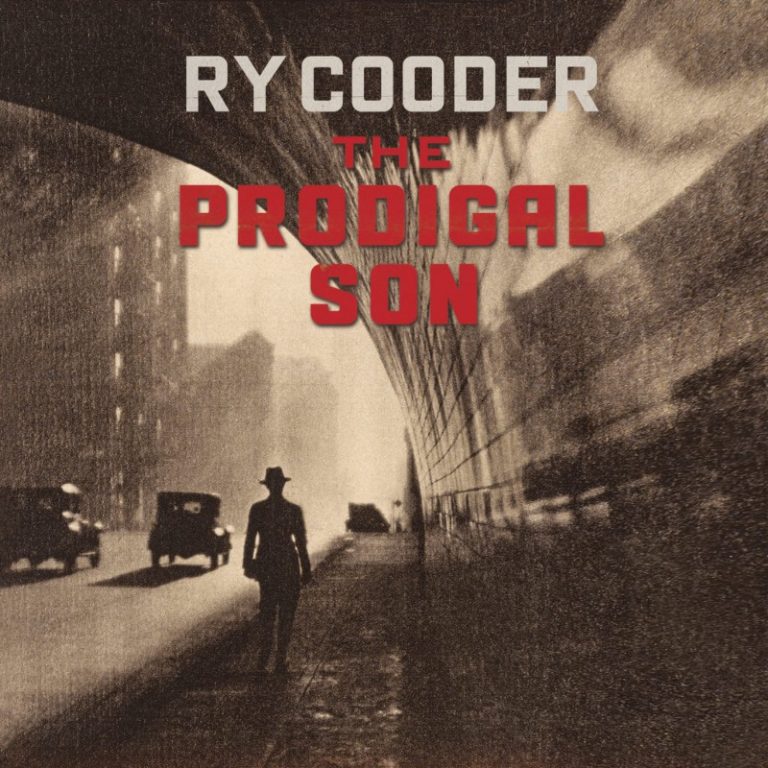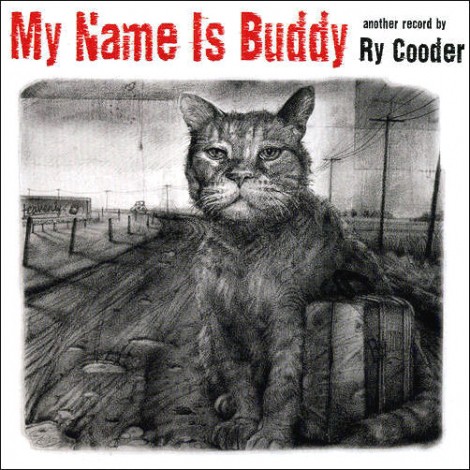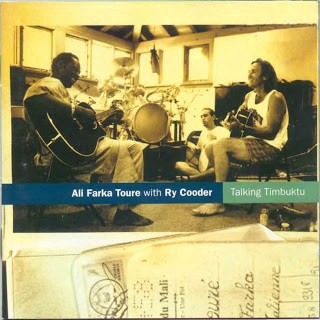Counting Crows — Saturday Nights and Sunday Mornings (2008)
“Sono un ebreo americano di origine russe che recita la parte di un afro-giamaicano. Quello che vorrei essere è un indiano, ma finirò per essere un cowboy”
A distanza di quasi sei anni dall’ultimo album “Hard Candy” (2002), sono tornati con un nuovo disco i Counting Crows. Questo quinto album in studio, arriva quindici anni dopo il bellissimo e fortunato “August and evrything after” (1993), si chiama Saturday nights and Sunday Mornings, e ci propone il consueto mix di rock, rock acustico e influenze country, il tutto coniugato dalla voce inconfondibile del leader della band Adam Duritz.
Il disco è fondamentalmente diviso in due parti: quella dedicata al caos dei “Sabati notte” quando “si commettono i peccati”, parte più elettrica e quella più calma, dedicata alla malinconia delle “domeniche mattina” quando invece “si pente”, parte più acustica.
I suoni del disco sono probabilmente ancora un po’ troppo in coerenza con gli ultimi lavori del gruppo a discapito di una nuova sferzata, di una nuova fase sonora, attesa come sempre, dai fans.
Nel disco ci sono le ballate che gli hanno resi famosi. Nella prima parte denominata “Saturday” le canzoni sono elettriche, veloci, energiche e sempre trascinanti, nella seconda parte denominata “Sunday” le canzoni sono acustiche, lente e sempre melodiche. E’ questa, una delle peculiarità dei Counting Crows, oltre a quella di curare molto gli arrangiamenti. Il loro lavoro sonoro sta nel saper produrre “intrecci” musicali, sta nel riuscire a fondere decine d’incastri elettroacustici, creando brani impeccabili e raffinati.
Non è facile dare un giudizio complessivo a quest’ultima fatica di Adam Duritz e compagni, il lavoro è ben strutturato, ben suonato, ben cantato, ben arrangiato, ben adattato ad ogni situazione vista anche la doppia personalità dell’album, eppure anche con tutti questi “ben” rimante tutto abbastanza anonimo. Probabilmente dopo questo lungo inverno ci aspettavamo, perché molto desiderato, un po’ più di “August”.
Ben tornati, in ogni caso, Counting Crows.