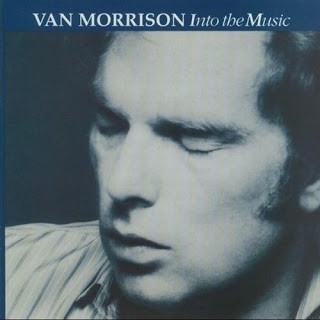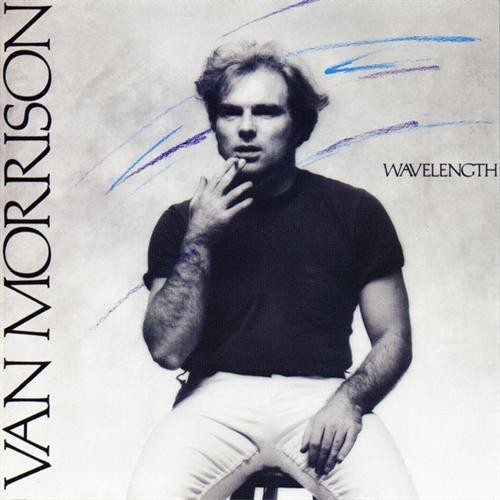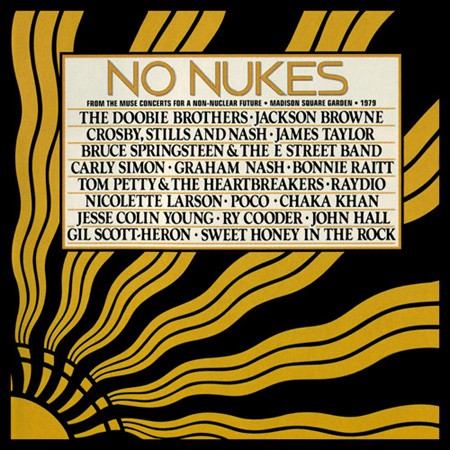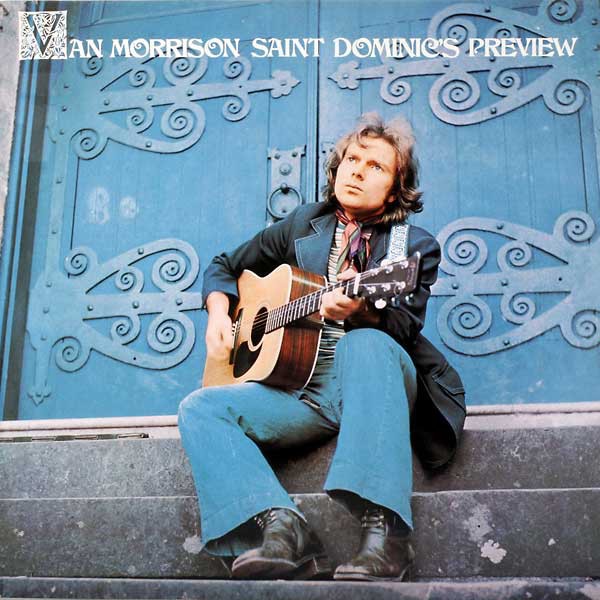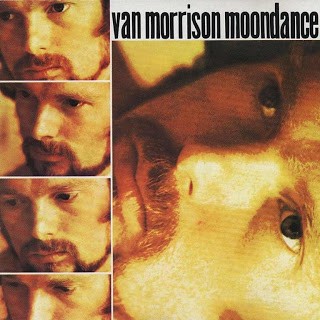Traffic — John Barleycorn Must Die (1970)
Doveva essere il suo primo disco solista, ma qualcosa ha fatto cambiare idea a quel genio di Steve Winwood, rimise la denominazione “Traffic” e cambiò il nome del disco che originariamente doveva chiamarsi “Mad Shadows”
I Traffic altri non sono che un trio, uno dei migliori che la scuola del rock abbia mai sfornato: Chris Wood ai fiati, Jim Capaldi alla batteria e il polistrumentista, cantante e compositore Steve Winwood. Ad onor di cronaca è utile ricordare che Steve all’età di quindici anni, si 15! creò la fortuna degli “Spencer Davis Group”. Questo trio di folk-pop tra i più interessanti, stimolanti e creativi degli anni Settanta, segnano con questo disco uno dei capolavori del pop-rock, un viaggio introspettivo ai confini tra il vecchio e un nuovo “ritmo sonoro”.
Ad un certo punto l’enfant prodige del rock britannico, Winwood, rimane folgorato dalla leggenda di John Barleycorn, un buffo omino dalla fisionomia variabile che nella tradizione popolare viene celebrato come la personificazione simbolica del Whisky e della Birra. E’ così che nasce “John Barleycorn Must Die”, capolavoro di semplicità e raffinatezza che alterna ipnosi ritmica a intensità lirica. Questo progetto viene offerto al pubblico in un periodo che è travolto dai furori di fine anni sessanta, i fiati tenui, la composta ritmica, l’atmosfera vocale, riescono ad ammaliare e a ipnotizzare i fan. Fu proprio questa compattezza a rendere “John Barleycorn” un‘avventura tanto provocatoria quanto originale, quasi il frutto di un’operazione chirurgica a cuore aperto.
Alcuni di voi si ricorderanno della sigla radiofonica di “Per voi giovani”, il brano era Glad, il riff ipnotico rimane ancora nella memoria di molti, come il disco del resto, che col passare degli anni venne considerato una delle pietre miliari del nascente “Progressive Rock”.
La spiegazione di tanta originalità è ancora oggi probabilmente da ricercarsi nella presenza del genio bambino, primattore ma antidivo, grande vocalist e virtuoso pluristrumentista Steve Winwood.