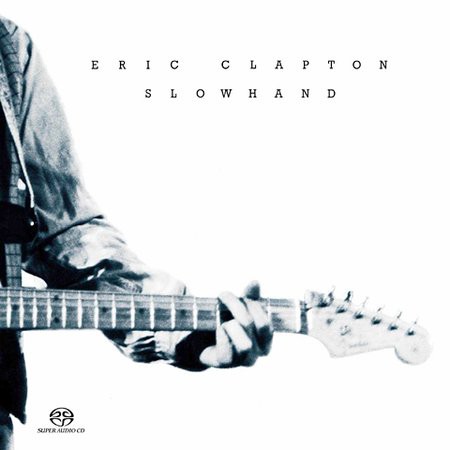Santana & McLauglin — Love Devotion Surrender (1973)
L’uscita di questo disco all’epoca passò in sordina. Probabilmente molti interpretarono questa uscita come un preciso disegno commerciale da parte della casa discografica. Ma per chi ha avuto occasione di ascoltare l’album avrà avuto modo di pensare: ne venissero di accordi commerciali con un risultato simile!
Il marchio che contraddistingue il disco è “ode alla chitarra elettrica”, e in questo caso ne rappresenta uno dei migliori mai suonati nella storia del rock.
E’ l’incontro tra due chitarre. Due chitarre che, si trovano, iniziano il dialogo, c’è una scoperta l’uno dell’altro, poi pian piano si sfiorano, si studiano e comincia un’amicizia. L’uno entra nel mondo dell’altro, per McLauglin si aprono spazi dolci e rarefatti, per Santana vertiginose velocità espressive.
Le due tecniche chitarristiche, sebbene molto diverse, concorrono a creare una miscela di suoni molto particolare, pressoché unica per quel periodo.
Ai virtuosismi del primo si contrappone il fraseggio del secondo, In tutto il disco si respira una profonda aria di spiritualità (soprattutto nelle mirabili pagine coltraniane, come è ovvio).
All’interno dell’album compaiono 5 tracce, di cui due sono tratte da lavori di John Coltrane (A Lovesupreme e Naima), due composte da McLaughlin (The Life Divine e Meditation) ed un altro è un arrangiamento di Santana-McLaughlin di un inno religioso tradizionale afro-americano, Let Us Go Into The House Of The Lord.
A Love Supreme inizia con un’intro a folle velocità di Carlos Santana. Poi il suo vorticare cessa e partono basso e percussioni. L’organo di Yasin/Young si fonde a meraviglia con le dinamiche del gruppo dettando il tema della melodia. Le improvvisazioni chitarristiche di Santana e McLaughlin si contrappongono, una sul canale destro, l’altra sul canale sinistro (impazzivo ascoltarla con il stereo del Rider Digest, da pochi anni c’era la stereofonia!), non una sfida, ma un botta e risposta come durante una funzione religiosa, poi partono i cori, che, pervasi dallo spirito, ripetono incessantemente “a love supreme”. È evidente fin da questo primo brano come l’influenza della spiritualità sia coltraniana sia del guru di McLaughlin e Santana, Sri Chinmoy, pervada in lungo ed in largo questo disco. Eccezionale.
Naima si apre con un’introduzione virtuosistica della chitarra (acustica) di McLaughlin, a cui dopo un po’ fa eco quella (sempre acustica) di Santana in accompagnamento. Un brano reso in modo molto intimistico e sicuramente adatto ad una composizione che Coltrane dedicò alla moglie mussulmana e che della cultura islamica risente molto quanto ad atmosfera musicale. Splendido.
The Life Divine è caratterizzata da una lunga intro che lentamente cresce d’intensità sonora e porta alla ribalta prima il rullio di una batteria e poi i suoni delle altre batterie, le percussioni e la chitarra di Santana. Il tema è dettato dalla chitarra di McLaughlin, cui si frappongono i cori dei musicisti. L’improvvisazione della chitarra di John e in antitesi quella di Carlos, creano un vortice di suoni. Ripartono i cori, accompagnati dalle chitarre e dalla ritmica, poi di nuovo improvvisazione di una delle chitarre, con il basso che, al contempo con il solo della chitarra, creano un altro vortice e per la terza volta partono i cori. Veramente curata e suggestiva l’evoluzione ciclica di questo brano. Ottimo.
Let Us Go Into The House Of The Lord è il brano più lungo dell’album, ben 15 minuti e 43 secondi. Un canto tradizionale riarrangiato dai due chitarristi. Intro di chitarra con sottofondo di batteria ed organo. Grande padronanza tecnica di Santana, anche McLaughlin sfoggia una straordinaria bravura tecnica creando intriganti vortici di note. Entrambe le chitarre sono protagoniste in questo brano, entrambe magistralmente coadiuvate, sia nella proposizione del tema dell’inno sia nell’improvvisazione. Un ottimo arrangiamento per un canto tradizionale particolarmente suggestivo.
Meditation, altra composizione di McLaughlin, è caratterizzata dal piano dell’autore, cui si accompagna in sottofondo la chitarra di Santana. Il tema è prima esposto dal piano, poi dalla chitarra. Un’altra esecuzione intimistica e poetica: una vera e propria meditazione orientale in musica. Bella.