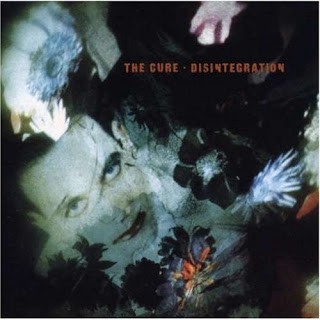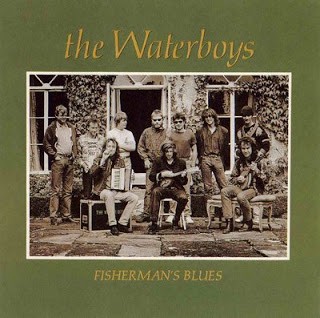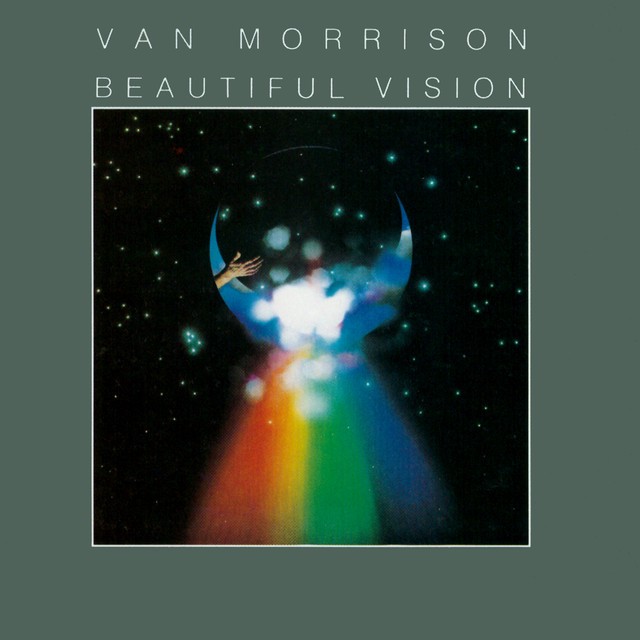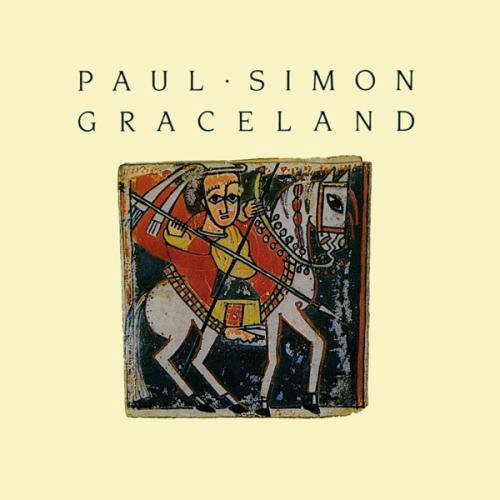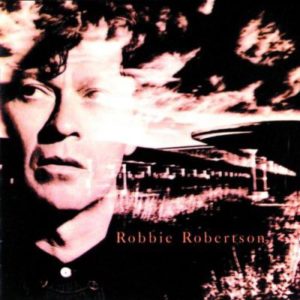The Smiths — The Queen is Dead (1986)
Esiste una teoria secondo cui gli anni Ottanta britannici hanno prodotto solo due nomi da salvare: Smiths e Japan. Gruppi presuntuosi quanto si vuole ma almeno capaci di musica vera. Eppure all’epoca soprattutto gli Smiths lasciavano qualche dubbio. Sono bravi, bravissimi nei pochi minuti di un 45 giri — si diceva di loro — meno quando si tratta di reggere i tre quarti d’ora di un album, niente vero per quel che mi riguarda.
Sì, in “The Smiths” e in “Meat is murder” ci sono dei vistosi cali di tensione ma, in “The Queen is Dead” no, è perfetto dall’inizio alla fine come non era accaduto prima e non sarebbe accaduto poi.
“The Queen is Dead” è stato il punto più alto della carriera degli Smiths e può essere considerato il ritratto dell’Inghilterra del ‘900 secondo Morrissey che, al di là del suo ostentato egocentrismo è riuscito a regalarci canzoni uniche, immediate e nello stesso tempo con una presa lirica inimitabile.
Gli elementi dei testi sono: l’amore, la morte e soprattutto un grande senso dell’umor. Le parole sono sottili e genialmente ambigue. Morrissey fruga nella letteratura (Oscar Wilde) e nella cinematografia (le loro copertine hanno sempre riferimenti cinematografici) ma riesce ad imprimere sempre il suo marcato senso autoironico. Ma, bisogna ricordare che, le parole di Morrissey non sarebbero così efficaci senza le melodie perfette del chitarrista Johnny Marr, che all’epoca seppe far canticchiare chissà quanti loro fans.
Queste due anime del gruppo, hanno creato un marchio di fabbrica inimitabile, quella di Morrissey, decadente, tormentata e sentimentale, sempre in bilico tra genialità e auto-flagellazione, tra sguardo crudo sul mondo e sfrenato intimismo, e quella del chitarrista Johnny Marr, tutta fatta di strepitose intuizioni musicali.
Fu un “matrimonio” perfetto che raggiunse l’apice proprio i quegli anni Ottanta, senza essere superati nel futuro da nessuno, nemmeno dalle loro singole prove.