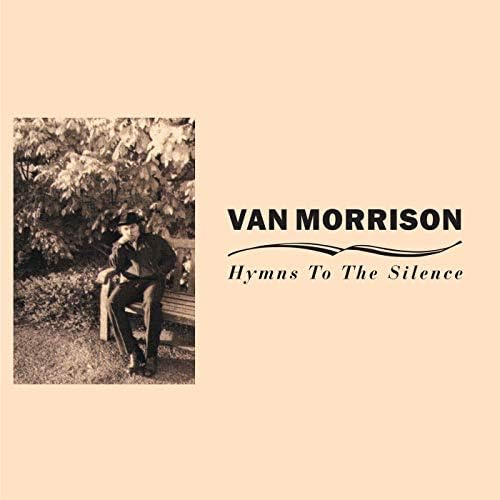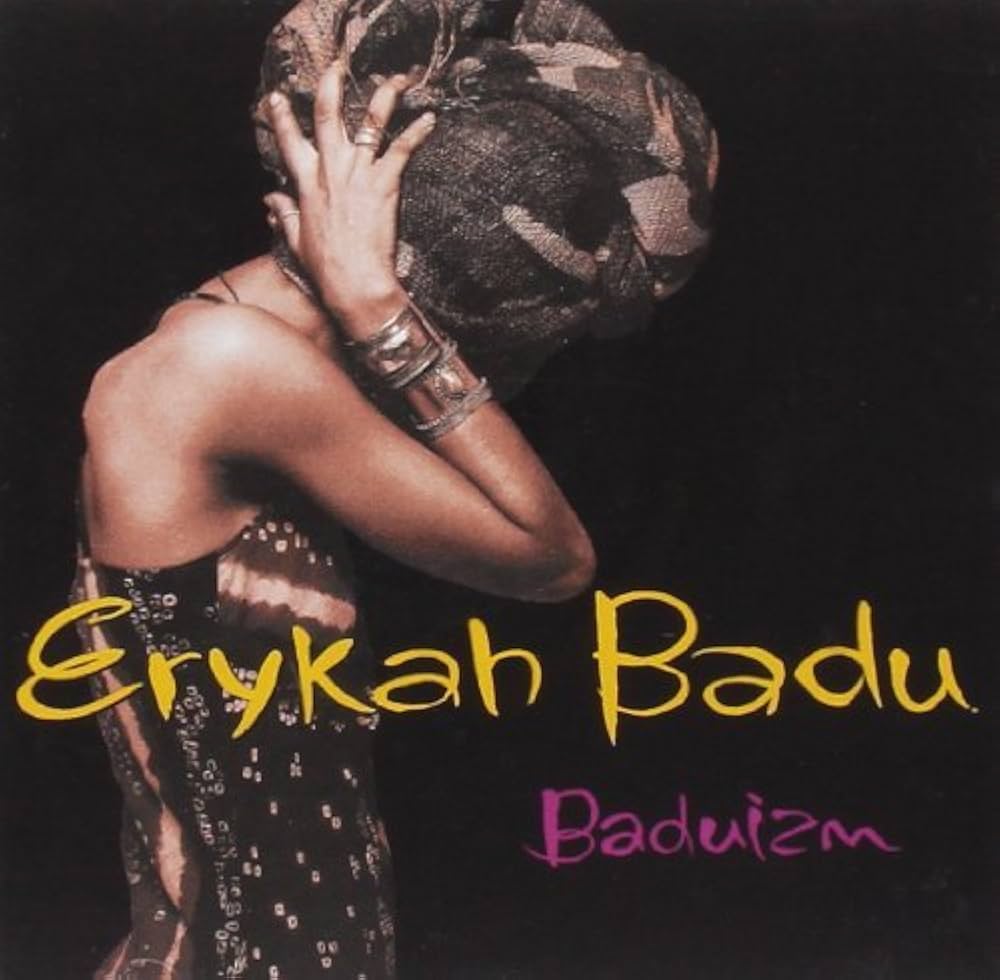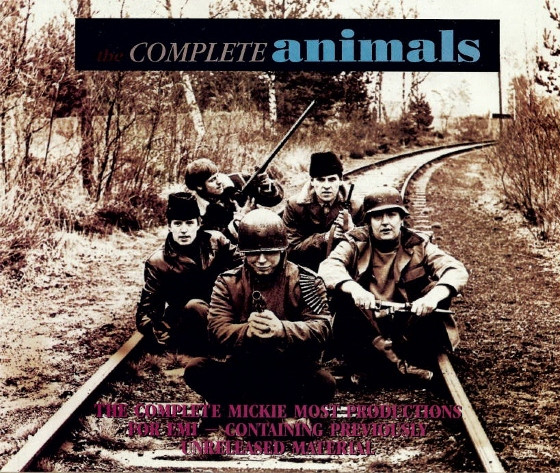My Favorites Albums #7/100
Ali Farka Tourè & Ry Cooder – Talking Timbuktu (1994)
[…] C’è un qualcosa che traspare dal disco che ricorda una ciclicità: l’amaro e il dolce, gli spazi brevi e ampi, il giorno e la notte, la terra e il mare. Ma quale mare? Il Mali non ha nessun sbocco al mare. Ed è questa una delle tante magie che la musica di questo disco riesce nella sua semplicità a generare. L’immaginare l’immaginabile. [continua…]
Questo disco fa parte di una lista casuale di album che mi sono particolarmente piaciuti, dall’età dell’adolescenza fino ai giorni nostri. Non segue un criterio cronologico né un ordine di preferenza.
Alcuni album sono stati colonne sonore di passaggi importanti, altri mi hanno accompagnato silenziosamente, a volte solo per una stagione. La lista mescola generi, stili, voci, epoche. Non è una classifica, ma una mappa emotiva, fatta di memoria, ascolto, risonanza. È anche un modo per ringraziare quegli artisti – noti e meno noti – per la bellezza, l’inquietudine, la forza o il conforto che la loro musica mi ha lasciato. La musica, del resto, non si spiega: si ascolta, si sente, si porta con sé.