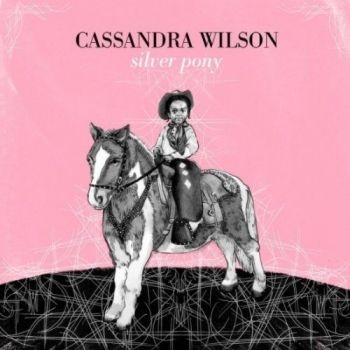Quante volte ci si chiede se un musicista ormai datato della scena artistica mondiale, con decine e decine di album pubblicati, abbia ancora qualcosa di nuovo da farci sentire? E’ molto probabile che, se il musicista non appartiene alla nostra sfera di preferenza, lo si liquidi subito, a volte ancor prima di ascoltarlo, con un bel “niente di nuovo”, “album inutile”, “ormai finito” ecc. ecc.; se invece è un nostro beniamino o ancor meglio apparteniamo alla sfera dei suoi fans incalliti, è molto probabile che il nostro giudizio sia “oscurato” dal classico velo affettivo che, per carità non è “pietoso”, ma senz’altro poco obbiettivo. Ecco, tutta questa premessa per arrivare a dire che, personalmente, pur appartenendo alla seconda sfera, quella dei fan incalliti e non da tempi recenti, serenamente affermo che Wrecking Ball è un buon album e il nostro sessantatreenne “The Boss” riesce a dirci ancora molto!
Un gradino al di sotto di Magic del 2007 e un gradino sopra di Working On a Dream del 2009, “Wrecking Ball” si colloca nella “via di mezzo”. Certo, siamo lontani dal suo ultimo capolavoro “The Rising” del 2002, escludendo quei due lavori leggermente atipici che sono l’acustico “Devils & Dust” del 2005 e quel folkloristico “We Shall Overcome: The Seeger Sessions” del 2006.
Gli album di Springsteen e di conseguenza i suoi testi rispecchiano sempre il periodo attuale e anche questo diciassettesimo album in studio “Wrecking Ball” ossia “palla demolitrice” non fa differenza. Se “Working On A Dream” portava un vento di speranza legata soprattutto all’ascesa di Obama alla presidenza Americana, “Wrecking Ball” riflette la società e il pensiero odierno ossia la recessione, la consapevolezza di vivere un periodo critico e difficile dovuto alla crisi economica che esaspera milioni di persone.
Un album per certi versi amaro quindi, dove non si risparmia nessuno, dai politici agli economisti, dagli amministratori ai banchieri, ma che al contempo, invita a non arrendersi, a continuare ad usare la rabbia, il motore che crea la forza per vincere. I temi sociali sempre in prima linea, ma non solo, anche storie di vita quotidiana, un “personale e politico” che si fondano in un tutt’uno. Un album che sottolinea alcuni aspetti negativi della vita come l’amarezza e la delusione ma che, come quasi sempre avviene, lancia un “messaggio” positivo e ottimista: sogno e speranza è ancora una volta il consiglio Springstiniano. Prendersi cura di noi per creare un futuro migliore per i nostri figli è il suo slogan preferito.
Le musiche ben amalgamate (come sempre) con il “senso” dei testi, creano tredici brani strutturalmente buoni. Si va da “We Take Care of Our Own” brano allegro e coinvolgente a “This Depression”, bellissima canzone lenta, probabilmente dedicata alla moglie Patti Scialfa, tra le più belle del disco. Da “Easy Money”, brano countrygheggiante a “Wrecking ball” altro ottimo brano con un riff tra i più orecchiabili. Dalla entusiasmante “Shackled and Drawn” a “Death to My Hometown”, un misto di celtico e gospel, terzo brano più bello del disco. Da “Swallowed Up”, brano testuale a “Land of Hope and Dreams” il brano più “springstiniano” dell’intero album. Se “Jack of All Trades” è un altro brano lento e riflessivo, “Rocky Ground” è un brano anomalo, una strana campionatura e una voce femminile lo rende il più innovativo del disco. “American Land” è una ballata energica mentre le ultime due: “You’ve got it” e “We are Alive” si mantengono nel “genere springstiniano” senza particolari emozioni.
Se la fisarmonica e il violino fanno riecheggiare il sound irlandese e il banjo è una reminescenza “seegeriana”, non bastano a far di questo Wrecking Ball un disco marcatamente folkanzi, è ancora il rock a fare da padrone. Il suono è energico, senza eccessi e, ancora una volta, chitarra, basso e batteria, riportano il Boss al stile classico a noi più caro.
Non entrerà tra i Top della discografia Springstiniana questo “Wrecking Ball” ma resta comunque un buonissimo disco, per nulla scontato ne tantomeno noioso e banale e anzi, quello che più conta, non lascia trasparire il senso di “vuoto musicale” che, a dire il vero, colpisce molti musicisti non più in tenera età.