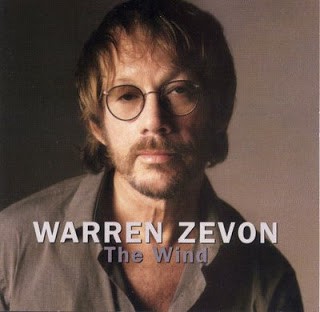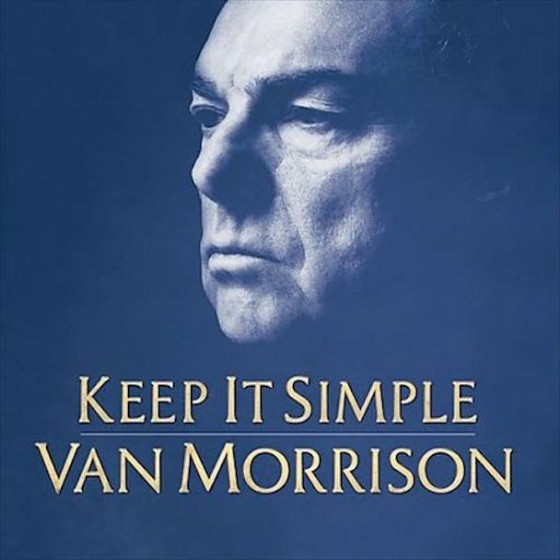Dopo diversi ascolti viene confermata la regola generale applicata ai dischi e quindi quella di ascoltare più volte le tracce prima di esprimere un giudizio. “La mia patria attuale” ha bisogno di serenità d’animo, di silenzio e di un ascolto attento. E poi dopo, quando la musica tace, di una riflessione silenziosa. Più e più volte.
“La mia patria attuale” è un disco intellettuale, quasi letterario.
La scelta di pubblicato il 21 gennaio non è casuale: il 21 gennaio (1921) è nato il Partito Comunista d’Italia e il 21 gennaio (1924) è morto Lenin. Due riferimenti importanti per l’artista, ancora fedele alla linea dei CCCP e CSI, di cui coltiva la memoria collettiva.
Se ci si ferma un attimo a riflettere non stupisce questa scelta. Zamboni è di Reggio Emilia, dove è nato il Tricolore e soprattutto terra resistente e partigiana. E i partigiani si definivano patrioti, senza vergogna: perché con il loro sacrificio hanno provato a lavare l’onta del fascismo e ridare dignità all’Italia.
“La mia patria attuale” traccia una visione approfondita sulle correnti incapacità di un’Italia che non sembra più in grado di valorizzare il proprio immenso passato culturale e sociale, lasciato ormai quasi all’abbandono e dove l’importante termine “Patria”, la terra dei padri, viene sempre più utilizzato con faciloneria per interazioni persino irrispettose di quell’aureo significato.
Esiste davvero l’Italia o è solamente una mera espressione geografica? Esistono davvero gli italiani? Ha senso cercare la nostra coscienza comune? Riusciremo ad andare oltre questo sciagurato “mare nostrum” di delusioni brucianti e promesse mancate? Sapremo svincolarci e liberarci dal disordine, dal cinismo, dalla paura e dall’ignoranza che sembrano condannarci a restare, per sempre, proni e piegati, in balia dei peggiori governi e di una classe politica che è incapace di guardare con fiducia costruttiva al futuro, incapace di offrire prospettive alternative, incapace di uscire dai soliti schemi mentali e dai soliti luoghi comuni, ma si ostina a vivere nella menzogna di uno sterile, paranoico e frustrante eterno presente, pur di conservare i propri privilegi e la propria posizione?
Per la prima volta in carriera l’ex-Cccp e Csi si lascia trascinare pienamente nel mondo cantautorale, un territorio che non è mai stato tra i suoi preferiti, ma nel quale sembra finalmente accedere con attenta curiosità e assoluta padronanza. La capacità compositiva è sempre stata una delle sue doti più spiccate, non solo in musica – è pregiata la sua carriera parallela di scrittore – e in questo progetto il cuore pulsante del pensiero dello Zamboni cittadino italiano prende il sopravvento su tutto il resto.
I dieci brani di “La Mia Patria Attuale”, ricchi di combattive sonorità di matrice folkeggiante, di una narrazione cantautoriale cruda e malinconica, di una vibrante e accattivante poesia, di chitarre e pianoforte, organo e mellotron, offrono al pubblico quello che, ad un primo ascolto, potrebbe apparire solamente un ingannevole e insensato conforto, un dolente susseguirsi di invocazioni a Dei inesistenti che si mostrano sordi alle nostre preghiere, ciechi e insensibili dinanzi alle dolorose tragedie che sconvolgono il mondo. In realtà, però, queste invocazioni sono rivolte soprattutto a noi stessi – agli sciagurati, ai reietti, ai diversi, agli emarginati, agli esclusi – spronandoli, attraverso quelle ritmiche e quelle percussioni che appartengono alla nostra storia comune, a rivoltarsi contro questa delirante e brutale visione della società.
A dominare non sono le chitarre distorte, l’elettronica ma è la voce, la sua voce. Che canta, racconta, sussurra sulla musica, creando dei momenti profondi e di forte impatto emotivo.